Da imalpensanti.it/2013/05/riviste-letterarie-del-novecento-lunita/ maggio 2013
L’Unità
“[…] la crisi tripolitana non è che il momento saliente della crisi generale della Voce. I gruppi della Voce non sono due, sono dieci, sono venti… Occorre dividerci. Io ormai non concepisco più La Voce che come un giornale settimanale di problemi politici, una specie di Critica sociale di vent’anni or sono, in cui la critica letteraria e filosofica faccia da contorno, da ornamento, da puntello ad un’edizione politica determinata”.
A questo punto Salvemini ha bisogno di un nuovo spazio culturale e politico nel quale esprimersi, ed attraverso il quale divulgare all’opinione pubblica le proprie posizioni. Codesta necessità acquista concretezza con la fondazione, avvenuta il 16 dicembre 1911, della rivista L’Unità. Il foglio si propone di affrontare senza riserve né rinunce di alcun tipo, i più importanti problemi del paese, dalla questione meridionale all’inarrestabile corruzione politica, passando per le imprescindibili riforme amministrative,tributarie e scolastiche. Di seguito, i punti fondamentali del documento programmatico del giornale,intitolato Che cosa vogliamo?, e pubblicato in due puntate sui numeri 13/14, 9/16 del marzo 1912.
Questa nostra posizione ideale e pratica, che continueremo a chiamare democratica spiega perfettamente perché siamo anche risolutamente antinazionalisti.
Nel nazionalismo noi vediamo un movimento fondamentalmente conservatore e antiproletario […], la volontà arbitraria di negare i problemi della nostra vita interna e di farli dimenticare con diversivi di avventure diplomatiche e militari, a vantaggio di tutti quegli interessi parassitari e antinazionali che da un vittorioso sforzo di riforme interne uscirebbero distrutti”.
Allo scoppio della Prima guerra mondiale, L’Unità si schiera dalla parte degli interventisti, illudendosi di poter trasformare il conflitto in quella che oggi chiameremmo una missione di pace. Salvemini si fa portavoce di siffatta, chimerica ambizione mettendo in gioco se stesso con la partenza per il fronte. A causa della defezione del fondatore e direttore, la rivista è costretta a sospendere le pubblicazioni in più di un’occasione.
Il giornale intanto sostiene la rivoluzione russa, ma assumendo una posizione differente dalla tradizionale teoria di eversione marxista che vedeva nella realizzazione dell’autogoverno operaio l’epilogo ideale. Il timore di una dittatura proletaria, nociva tanto quanto quella capitalistica, spinge L’Unità ad intraprendere una nuova via, “nella fondazione di un nuovo raggruppamento politico, che dovrebbe assicurare alle masse contadine uno stato maggiore costituito dall’élite della gioventù combattente”. Il tentativo fallisce, e la rivista chiude i battenti, pubblicando l’ultimo numero, il 53, il 30 dicembre 1920.
Da www.supergulp.biz
Con il n. 53 del 30 dicembre 1920 Salvemini sospende le pubblicazioni.
Da www.zeropost.it del 12 dicembre 2019
Dalla crisi della Voce ai tempi della guerra di Libia nasce la rivista L’Unità. Il suo fondatore e direttore, Gaetano Salvemini (1873-1957) è una delle personalità più notevoli della cultura italiana del Novecento: studioso dei problemi del meridione, inclemente avversario - di parte democratica - di Giolitti; insigne maestro di metodo storico e di impegno civile all’università di Firenze, fuoruscito in conseguenza del fascismo (di grande interesse le sue Memorie di un fuoruscito).
La fondazione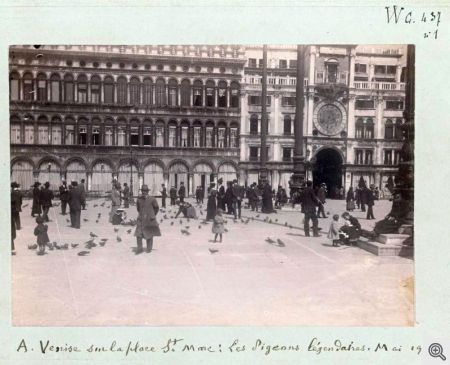
La rivista nel dettaglio
L’Unità si distingue nel panorama delle riviste analizzate in altri articoli per il suo risentito tono di protesta, di denuncia morale. Si manifestano le caratteristiche di fondo di Salvemini, che non solo fu un dottrinario ma si attribuì puntigliosamente per tutta la vita la parte di colui che è venuto a combattere le fumose astrazioni dei politici da tavolino. La passione dell’intellettuale piccolo borghese di fare bei discorsi teorici che non cavano un ragno dal buco, la vocazione tutta italica di creare castelli in aria e lasciare le cose come sono.
L’ammaestramento de L’Unità fu e rimane sostanzialmente un ammaestramento di metodo e costume. Più problemi che sistemi, più cose che teorie. Contro le falsificazioni della propaganda, rispetto della verità; contro ogni forma di fanatismo, senso di responsabilità. Guardare più ai risultati che alle buone intenzioni; meno ideologie, più documenti.
N. Bobbio
Non è questa la sede per un esame dell’opera di Salvemini, che non si riduce soltanto alla rivista L’Unità. Si può solo sottolineare che nel complesso - e pur con qualche riserva su certe posizioni – la battaglia di Salvemini, dalle iniziali posizioni socialiste a quelle radical democratiche, si è svolta su due piani. Uno di metodo e l’altro di costume, che poi finiscono per diventare una cosa sola. Quale? La battaglia metodologica per la concretezza, per un sano empirismo politico diventa tensione etico civile, impegno morale contro la retorica, contro i dogmatismi ideologici di destra e sinistra.
Nell’Italia del primo Novecento, dannunziana e nazionalista, Salvemini è certo un isolato e tuttavia bisogna partire da lui per capire i vari Gobetti e Rosselli.
Da www.bibliotecaginobianco.it
I problemi affrontati da L'Unità (1911-1920) sono ancora presenti nelle strutture del Paese: le norme-costitutive di una condizione democratica, i rapporti fra socialismo e democrazia, la questione meridionale, il problema tributario, la questione agraria, le riforme elettorali, l'emigrazione, i temi polemici del protezionismo e del liberismo, la questione scolastica.
Il determinarsi storico di questi problemi, la ricerca di un metodo positivo di analisi, la formulazione d'organiche prospettive di soluzione furono l'oggetto della discussione unitaria. Vi parteciparono gli studiosi ed i politici più probi dell'Italia pre-fascista: Luigi Einaudi, Benedetto Croce, Antonio De Viti De Marco, Edoardo Gìretti, Gino Luzzatto, Umberto Zanotti-Bianco, Ettore Ciccotti, Giustino Fortunato, Rodolfo ed Ugo Guido Mondolfo, Leonida Bissolati, Giovanni Carano - Donvito, Carlo Mannelli. Ed accanto ad essi i giovani che avrebbero in seguito partecipato attivamente alla lotta antifascista e alla Resistenza: Piero Gobetti, Ernesto Rossi, Piero Calamandrei. E gli eretici Giuseppe Prezzolini, Giovanni Ansaldo, Virginio Gayda, Balbino Giuliano, con alcuni dei quali lo stesso Salvemini, negli ultimi anni della Rivista, condusse polemiche che egli stesso definiva discussioni extra moenia.
Un complesso di presenze che contribuì a fare de L'Unità il documento giornalistico più spregiudicato, coraggioso e acuto del suo tempo.
Testimonianze validissime rivedrà inoltre lo storico sulle maggiori vicende internazionali del secondo decennio del nostro secolo: la guerra Libica, la Triplice Alleanza, la Guerra mondiale, i Trattati di pace, i problemi del Primo dopoguerra.
Era dunque necessario realizzare al più presto una “antologia”, quanto possibile ampia e coerente de L'Unità. Il compito, per desiderio espresso del Salvemini, - che vi collaborò con consigli e suggerimenti - venne assunto e assolto da Beniamino Finocchiaro, discepolo vivo e fedele del Maestro.
L'Unità di G. Salvemini
powered by social2s

