Salvemini e il 1919
Il Mondo, 22/12/1951
L'autore ha ricostruito la crisi del primo dopoguerra italiano (1919-1920) quale apparve a Gaetano Salvemini. Fonti principali di questa ricostruzione sono stati gli articoli di Salvemini sul suo settimanale L'Unità e i discorsi da lui pronunciati in Parlamento. Le parole e i giudizi fra virgolette di cui non si cita la fonte, sono stati uditi dalla viva voce di Salvemini.


D'altra parte, nazionalisti ed altri uomini di destra, quando fu chiaro che l'Italia non avrebbe ottenuto alla conferenza della Pace l'adempimento delle promesse fattele nel trattato di Londra, iniziarono una campagna di stampa sul tema della vittoria «mutilata», affermando che l'Italia dopo aver vinto la guerra aveva perso la pace. Dichiarazioni come queste, fatte dalle stesse persone che avevano voluto l'intervento, non potevano che contribuire ad acutizzare quello stato eli nevrastenia in cui era piombata parte della popolazione.
La posizione di Salvemini nel l'immediato dopoguerra era equidistante da quelle dei nazionalisti e dei socialisti. Egli aveva voluto l'intervento, ma in uno spirito ben diverso dai nazionalisti. Con Bissolati e gli altri interventisti democratici, egli aveva creduto che fosse nell'interesse dell'Italia impedire una vittoria tedesca, ma al tempo stesso aveva creduto nel sogno della guerra combattuta per porre fine a tutte le guerre, e negli ideali wilsoniani di una pace giusta, basata sul principio di autodecisione dei popoli. Salvemini si accontentava dell'occupazione dei territori abitati da italiani che erano sotto il dominio austriaco, ma era contrario ad annettersi altri territori abitati da popolazioni straniere, come era contrario ad ingrandimenti coloniali. D'altro canto ormai egli aveva ben poco in comune coi massimalisti italiani. Non credeva nel mito russo, si opponeva all'idea di una dittatura proletaria, e dubitava che nell'Italia del 1919 vi fossero le condizioni per una rivoluzione sociale di vasta portata. Seguendo una via di mezzo tra nazionalisti e socialisti si attirò da un lato le accuse dei primi di essere un «rinunciatario» (perché durante l'intero corso della guerra si era opposto risolutamente al programma di annessione della Dalmazia), e la diffidenza dei secondi che non gli perdonavano il suo interventismo.
Il contrasto fra le due anime della politica estera italiana quella democratica e quella nazionalista, che era rimasto allo stato latente durante gli anni di guerra, si manifestò subito dopo la cessazione delle ostilità. E' storia recente e molti dei protagonisti sono ancora fra di noi. Ci limitiamo a ricordare qualche fatto per i lettori più giovani. Durante l'ultima fase della guerra, sembrò che il ministero Orlando-Sonnino avesse accettato la linea democratica di politica estera propugnata dal gruppo bissolatiano. Ma dopo la vittoria Sonnino tornò al programma del patto di Londra che prometteva all'Italia la Dalmazia, mentre lasciava Fiume alla Croazia. Bissolati, che era allora ministro, senti di non poter più far parte di un governo che continuava a seguire una politica che egli giudicava nazionalistica, e rassegnò le sue dimissioni alla fine del 1918. Egli intese proporre all'opinione pubblica la scelta fra le due politiche in un discorso che si preparava a pronunciare l'11 gennaio del 1919 al Teatro alla Scala, ma un gruppo di nazionalisti con Mussolini alla testa gl'impedì di parlare coprendo la sua voce con clamori e accuse di essere un «vile rinunciatario».

Venuta meno la speranza che Bissolati potesse difendere le sue idee alla conferenza della Pace, Salvemini ripose le sue speranze nel presidente Wilson, l'uomo da lui ammirato e le cui parole aveva spesso citato con consenso nel 1917 e nel 1918 nell'Unità. A Sonnino “decrepito superstite dell'era bismarckiana” Salvemini contrapponeva ora Wilson, “l'uomo di buona volontà”, aggiungendo che i democratici italiani avrebbero dovuto considerare Wilson e non Sonnino come il loro “fiduciario” e “ministro degli Esteri”. La fede di Salvemini nel presidente Wilson cominciò ad essere scossa soltanto quando si accorse che Wilson si lasciava raggirare da Lloyd George e Clemenceau, veniva sconfessato nel suo stesso paese, e scendeva a compromessi.

In Italia l'idea della Società delle Nazioni incontrò l'ostilità degli ultranazionalisti e lo scetticismo di quei conservatori per i quali la patria rimaneva «il supremo valore». Rispondendo a Balbino Giuliano il quale facendo il nazionalista definiva la lega, come «un'utopia anglosassone» Salvemini ribatté che la prima guerra mondiale era stata per il sentimento di nazionalità quel che la guerra dei Trent'anni era stata per il sentimento religioso. “La guerra dei Trent'anni non estinse le religioni, ma mostrando la folle sterilità delle guerre di religione, vi pose termine. La Lega non pretende di rendere tutte le nazioni eguali giuridicamente e di fatto. Il forte rimane forte e il debole rimane debole. La Lega costringe sia i forti che i deboli a non fare la guerra. E ciò va a tutto vantaggio dei deboli. E l'Italia, piaccia o meno ai nostri nazionalisti, non è la nazione più forte: essa è la più piccola delle grandi potenze e la maggiore fra le piccole potenze». Troviamo Salvemini fra i componenti del comitato centrale della “Lega Italiana per la Società delle Nazioni”, di cui era presidente Bissolati, che tenne il suo primo congresso a Milano nel dicembre del 1918.
Alla conferenza della Pace, mentre Sonnino chiedeva la Dalmazia in base al patto di Londra, Orlando rivendicava Fiume in base al diritto di autodecisione. Il gruppo bissolatiano non esitò a criticare l'atteggiamento della delegazione italiana, facendo notare le contraddizioni in cui s'impigliavano Orlando e Sonnino, quando chiedevano il rispetto del principio di nazionalità a Fiume e la sua violazione in un territorio abitato in grandissima maggioranza da slavi. I bissolatiani sostennero che il patto di Londra non avrebbe dovuto essere del tutto accantonato o dimenticato, ma, piuttosto, che esso doveva essere usato come monnaie de change per nuove trattative. La delegazione italiana avrebbe dovuto cedere con buona grazia sulla questione dalmata, chiedendo come contropartita il ritorno della città di Fiume lasciato dal patto di Londra alla Croazia nonostante fosse abitata in massima parte da italiani. I bissolatiani arrivavano a capire che non essendo stato uno dei firmatari del patto di Londra il presidente Wilson si opponesse alla cessione della Dalmazia all'Italia, ma non potevano più seguirlo quando negava all'Italia anche la città di Fiume.


Troviamo infatti nell'Unità (10 maggio 1919) i familiari argomenti sull'utilità della rnonarchia come moderatrice dei partiti. Ma non si poteva dire che neanche in questo momento egli fosse un monarchico a tutti i costi. Era convinto che nell'Italia del 1919 vi fossero la necessità e le condizioni per attuare delle ampie riforme che l'avrebbero trasformata in un paese effettivamente democratico. Fra queste, le più urgenti erano una riforma agraria, che soddisfacesse gradualmente l'aspirazione dei contadini a divenire proprietari delle terre da essi coltivate; un'ampliamento e miglioramento delle leggi sulle assicurazioni sociali; il decentramento della pubblica amministrazione; e la riforma scolastica. In un'intervista data a L'Italia del Popolo, Salvemini dichiarò essere necessario conoscere il pensiero del re circa la necessità di tali riforme, e che, nel caso che il re vi si fosse dichiarato contrario, egli si sarebbe volentieri unito ai repubblicani. E riassunse questo punto di vista nel motto: “Colla monarchia se è possibile, colla repubblica se necessario” (L'Unità, 10 maggio 1919).
Intanto era chiaro dalle reazioni dei lettori che L'Unità stava svolgendo una funzione assai utile. Durante gli anni della guerra Salvemini aveva mantenuto un'attiva corrispondenza con molti giovani ufficiali di complemento al fronte che cercavano nell'Unità un orientamento politico e morale. Questa corrispondenza continuò nell'immediato dopoguerra e le postille in cui Salvemini commentava le idee suggerite dai lettori, furono spesso fra le cose più interessanti del giornale. Sorgevano intento in varie parti d'Italia, altri giornali e riviste pubblicati da giovani i quali si erano formati leggendo L'Unità, e diffondevano idee affini. Ricorderemo Volontà, Calabria, Energie nuove. Ascesa, Educazione nazionale, Vita, Risposta. Salvemini le seguiva con grande interesse e sperava che “dopo dieci anni di lavoro esse avrebbero contribuito ad un rinnovamento della vita politica italiana”. A chi si rivolgeva a lui per consiglio, egli non si sentiva di offrire alcuna panacea.
“I giovani debbono aver fede in se stessi, e cioè non debbono cercare di mettersi al seguito di uomini vecchi o nuovi; essi debbono lasciarsi guidare dalla loro ragione, non debbono prender nulla alla leggera, e debbono studiare, studiare, studiare” (L'Unità, 11 gennaio 1919).

Dietro suggerimento di un ufficiale reduce dalla guerra, con cui Salvemini si era tenuto in corrispondenza, fu indetta una riunione degli amici dell'Unità. Il 23 febbraio 1919 convennero a Firenze una cinquantina di persone. Alcuni espressero il desiderio che L'Unità divenisse qualcosa di più di un semplice periodico politico, mentre altri parlarono della necessità di fondare un nuovo partito. Si decise di fondare un gruppo d'azione a Firenze e di promuovere la creazione di gruppi simili in altre città. Come primo suo compito il gruppo fiorentino si propose di fare una campagna a favore della proporzionale e del voto alle donne, e come primo tema dei suoi studi scelse la riforma della burocrazia. Ben presto sorsero altri gruppi di “unitari” nelle principali città italiane. A capo del gruppo torinese troviamo Piero Gobetti, allora ventenne.
Frattanto, continuava sulle colonne dell'Unità la discussione fra coloro che erano favorevoli all'idea di fondare un nuovo partito e quelli che vi erano contrari. Salvemini si dichiarò favorevole a costituire un'organizzazione più agile e più snodata, fino a quando la maggioranza degli amici del giornale non si fosse mostrata favorevole all'idea del partito. Questa si chiamò “Lega democratica per il rinnovamento della vita pubblica italiana”.

Nel 1920 la lega contava oltre 300 iscritti. Questa cifra assai modesta, non dà un'idea adeguata della funzione che la lega avrebbe potuto svolgere se gli avvenimenti avessero preso uria piega differente. Essa contava fra i suoi componenti noti intellettuali e professori di università, giornalisti, scrittori, scienziati, ciascuno dei quali era in grado di influenzare molta gente. Anche l'influenza dell'Unità si doveva più che al numero delle copie che se ne vendevano alla qualità dei collaboratori e dei lettori.
Il programma della lega era un programma a lunga scadenza, che presupponeva delle condizioni normali di vita democratica. Nel 1920 cominciò l'offensiva fascista, i democratici furono costretti a combattere per sopravvivere, ed una seria lotta per le riforme divenne impossibile.
Nel 1919 la lega si concentrò sulla campagna contro il collegio uninominale e per la rappresentanza proporzionale. L'Unità aveva già cominciato a discutere questo problema nella primavera del 1918, perché Salvemini era persuaso che la vecchia legge elettorale col collegio uninominale avesse aiutato non poco Giolitti a racimolare le sue grandi e supine maggioranze, e che fosse urgente introdurre un sistema che consentisse alle minoranze di farsi sentire.
Questa esigenza fu fatta valere da diversi altri gruppi oltreché dagli “unitari”, e la pressione esercitata da più parti insieme, condusse ad una modificazione della legge elettorale, sicché le elezioni generali del 1919 furono fatte col sistema della proporzionale.


L'Unità continuava intanto a seguire gli avvenimenti della politica interna ed estera, i problemi educativi, e insisteva nella sua campagna contro il protezionismo.
Appena finita la guerra quando le minacce dei massimalisti raggiunsero il parossismo, anche Salvemini pensò per un momento che potesse verificarsi un moto rivoluzionario provocato ancor più dalla cieca opposizione alle necessarie riforme fatta dai conservatori, che dall'attività dell'estrema sinistra. Ma quando nell'aprile del 1919 vide fascisti ed arditi incendiare impunemente la sede dell'Avanti!, mentre per tutta reazione i socialisti si limitavano ad organizzare uno sciopero di protesta ed una colletta per fare uscire di nuovo il giornale, egli comprese che la rivoluzione non vi sarebbe stata. “L'organo centrale del movimento rivoluzionario, la fiaccola a cui i fedeli guardavano con religioso fervore, l'Avanti!, è stato brutalmente saccheggiato, senza che ne seguisse immediato e spontaneo lo scoppio della rivoluzione”, egli scrisse. “Se i capi socialisti non avessero perso ogni senso della realtà nella loro aspettazione del millennio, dovrebbero imparare molto da questa esperienza. Ma, probabilmente, essi continueranno ad attendere il millennio, provocando al tempo stesso dei disordini sporadici e facendo il giuoco dei peggiori elementi della borghesia e della burocrazia. Al massimo otterranno il ritorno al governo dell'onorevole Giolitti” (L'Unità, 26 aprile 1919). Previsione che trovò conferma nei fatti successivi.
Al principio del luglio 1919 l'agitazione contro il carovita provocò sommosse in varie città della Romagna e della Toscana, ed alcuni osservatori credettero che l'ora della rivoluzione socialista fosse scoccata. Vennero saccheggiati dei negozi, vennero requisite delle merci che furon portate alle Camere del lavoro per essere distribuite a basso prezzo fra la popolazione. Salvemini notò che alcuni giornali conservatori, fra cui La Nazione di Firenze, si schierarono per alcuni giorni dalla parte delle folle tumultuanti, e giunse alla conclusione che i circoli di destra soffiavano sul fuoco con un piano ben definito: “tutto ciò che serve ad accumulare l'odio delle altre classi contro gli operai, spiana la via alla reazione. E cosa può meglio favorire questo piano che le requisizioni a danno dei bottegai e dei contadini?”. Mentre i conservatori agivano da rivoluzionari Salvemini riscontrò che nelle giornate di luglio i socialisti rivoluzionari avevano agito in senso conservatore. In alcune città essi avevano impedito che scoppiassero altri tumulti; dove i tumulti erano già scoppiati non si erano opposti alla requisizione delle merci da parte dei dimostranti per non mettersi contro le folle e conservare cosi la loro fiducia. In breve essi avevano fatto di rutto per limitare la durata dei disordini e per localizzarli. Ma mentre agivano avendo di mira lo spegnimento dell'incendio, i socialisti continuavano a dar fiato alle loro trombe rivoluzionarie. Salvemini ripeté ai massimalisti l'avvertimento: “A che serve la fraseologia rivoluzionaria, quando non conduca ad una rivoluzione seria, se non a facilitare lo scoppio di inutili sommosse? ... Da una serie così insensata di eccitazioni, tumulti, e ritorni alla normalità, cosa può derivare alla fine se non una mostruosa reazione a base di stati d'assedio e di tribunali militari?”. Non dovevano passare quindici mesi che la prevista reazione era già in atto.

Quando nel settembre del 1919 D'Annunzio marciò su Fiume, Salvernini non si lasciò trasportare dall'esaltazione patriottica che si impossessò di molti giovani generosi, fra i quali diversi suoi amici, che li portò a seguire il poeta. Egli invece deplorò la sedizione militare (L'Unità, 18 settembre 1919, L'incidente di Fiume), e prese posizione nel senso che Orlando, Nitti e i comandanti dell'esercito e della marina avevano una responsabilità ancora maggiore per il pronunciamiento di quanta non ne avesse lo stesso comandante D'Annunzio. Ritenne i ministeri Orlando e Nitti responsabili per aver lasciato ai militari nei territori contestati al confine colla Jugoslavia funzioni di governo che avrebbero dovuto essere affidate alla autorità civili. Salvemini insistette affinché i veri colpevoli della sedizione militare fossero trovati e inesorabilmente puniti, in modo che gli alti gradi dell'esercito e della marina capissero una buona volta che i militari debbono essere «dei semplici strumenti dello Stato» e che il loro compito è quello di «obbedire» e non di «sovrapporre» la loro volontà a quella del governo.
La gravità dell'avventura fiumana fu messa pienamente in luce quando dopo diversi giorni la censura lasciò passare la notizia che D'Annunzio era sbarcato in Dalmazia alla testa delle sue truppe irregolari, era stato acclamato dal governatore della Dalmazia, viceammiraglio Millo, e che Millo aveva proclamato che le sue truppe non avrebbero mai sgomberato nessuna parte della Dalmazia assegnata dal patto di Londra all'Italia. Salvemini criticò il presidente del Consiglio Nitti perché non aveva immediatamente destituito l'ammiraglio Millo e lanciò parole di sfida ai capi militari:
“Noi abbiamo il diritto di sapere una volta per sempre chi ha comandato in Italia negli ultimi mesi: i soldati di professione, o i ministri designati bene o male dal Parlamento a governare il paese nella forma voluta dalle leggi, a cui i militari di professione debbono obbedienza. Noi abbiamo il diritto di sapere se l'Italia è un paese amministrato da poteri civili o è invece soggetto alla dittatura militare... Se il viceammiraglio Millo ha con sé altri ammiragli oppure tutto l'esercito e la marina, egli sa bene quel che deve fare: sbarcare ad Ancona, marciare su Roma, deporre il re, chiudere la Camera, e proclamarsi dittatore. E noi, che non vogliamo alcuna dittatura militare, sappiamo benissimo quello che noi dobbiamo fare, e ci dichiariamo pronti, se vi saremo costretti dalla mancanza di coscienza dei militari, a dar man forte ai partiti rivoluzionari per distruggere un Esercito e una Marina che, se si ribelleranno contro le autorità civili, dimostreranno di essere una minaccia per le libertà civili e per il normale sviluppo della vita nazionale. O il viceammiraglio Millo deve andare a Roma a sciogliere la Camera; o il governo che rappresenta la Camera deve destituire e processare il viceammiraglio Millo” (L'Unità, Il bivio 27 novembre 1919).

Avvicinandosi le elezioni generali (che si fecero poi il 16 novembre del '19) la “Lega per il rinnovamento” decise di non presentare dei candidati propri. Ma i suoi componenti si impegnarono a non fare accordi coi massoni, con i conservatori in veste di democratici, e con coloro i quali erano stati contrari all'entrata in guerra dell'Italia, quale che fosse il loro colore politico. I membri della lega furono invitati ad appoggiare i candidati presentati dai Combattenti oltre a quelli che avevano un programma simile al proprio. Salvemini decise di portarsi candidato, e consigliò altri amici a fare altrettanto, persuaso che occorresse infondere sangue nuovo in Parlamento, e che anche un gruppo di deputati di idee affini a quelle del Rinnovamento, per quanto piccolo, avrebbe potuto influenzare molti altri e sarebbe servito a smuovere le acque. Per questo compito egli contava soprattutto su uomini come Bissolati, De Viti de Marco ed Edoardo Giretti.
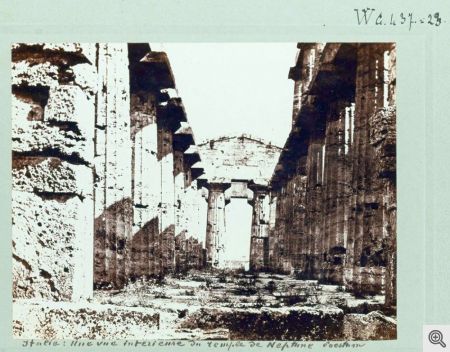
L'influenza di Salvemini nella redazione del programma elettorale dei combattenti della provincia di Bari balza agli occhi a chiunque ne confronti il testo colla dichiarazione di princìpi della "Lega per il rinnovamento". Specialmente in materia di politica estera il manifesto elettorale era di indirizzo chiaramente bissolatiano. Alcuni cambiamenti ed aggiunte furono introdotti per dar posto a problemi d'indole locale.
Salvemini fece una dinamica campagna elettorale, girando in automobile per i vari paesi del collegio, e parlando più volte alle folle in linguaggio semplice e chiaro. Anche questa volta parlò ai contadini e per i contadini come aveva già fatto durante la campagna elettorale del 1913.
Le elezioni del 1919 furono dopo molti anni le prime elezioni generali in cui il governo non intervenne a favore di un partito né manipolò i risultati come aveva fatto Giolitti per tre volto di seguito. Tuttavia, a Bitonto, già teatro di violenze elettorali nel 1913, il partito contrario a Salvemini riprese la vecchia tattica d'intimidazione dei seguaci di Salvemini e provocò dei sanguinosi tafferugli, mentre le autorità di polizia continuarono nelle vecchie abitudini consistenti nel lasciar mano libera ai malviventi e nel mettere al fresco i fautori di Salvemini. Questi telegrafò al primo ministro Nitti informandolo di quanto stava avvenendo a Bitonto, aggiungendo che questa volta non se l'era sentita di fare da pacere come nel 1913, e che aveva consigliato ai suoi seguaci a difendersi. Nitti rispose di aver dato ordine al prefetto di punire i responsabili dei disordini. In effetti gli elettori di Salvemini uccisero il capo dei “mazzieri” di Bitonto, ossia quello stesso criminale che si era distinto nelle violenze elettorali del 1913 e del 1919. Questa volta non essendosi verificati gli intrighi e le frodi a danno di Salvemini che avevano caratterizzato l'elezione del 1913, questi riuscì il secondo fra gli eletti nell'intera provincia con 16.000 voti di preferenza.
Enzo Tagliacozzo

