Non Mollare (1955), a cura di Mimmo Franzinelli, Bollati Boringhieri 2005
Piero Calamandrei (Nota 1, Nota 2, Nota 3)
Il manganello, la cultura e la giustizia
L’apparizione del fascismo risvegliò in molti italiani fino a quel tempo rimasti estranei ai partiti, il senso del dovere politico. Prima della guerra era largamente diffuso tra gli uomini di cultura il pregiudizio che la politica fosse un’attività di ordine inferiore, da sfaccendati o da faccendieri: e anche dopo la guerra i giovani migliori, appena smobilitati, si erano ridati a corpo morto ai loro studi, per riguadagnare gli anni perduti. Ma quando lo squadrismo incominciò a insanguinare le piazze e le campagne d’Italia, gli spari all’angolo della via e il bagliore delle camere del lavoro incendiate costrinsero anche gli appartati nelle biblioteche ad alzare la testa dai libri e ad affacciarsi alla finestra. E per una quantità di gente senza partito il problema politico si impose coll’urgenza di un problema morale, che riproponeva ad ogni galantuomo il dovere civico di assumersi la sua parte di responsabilità di fronte ad un rigurgito di violenza criminale che minacciava di distruggere le basi della civiltà.
Questo avvenne fuori dagli schemi delle vecchie organizzazioni di partito, quasi per coagulazione spontanea di tutti coloro che non volevano esser complici in quella vergogna: non sarà mai detto abbastanza che la prima opposizione al fascismo, quella che continuò sotterranea ed invincibile per vent’anni e che sboccò alla fine nella Resistenza, mosse da un impulso prima morale che politico: fu un’insurrezione della ragione umana contro il ritorno della bestialità. Mentre i fascisti lavoravano a suon di manganellate a approfondire la separazione tra “nazionali” e “antinazionali” (e presero di lì l’avvio le ferree distinzioni tra reprobi ed eletti, che ancor oggi continuano a mettere in pericolo la pace del mondo), uomini di diverso ceto e di diversa cultura sentivano il bisogno di ritrovarsi e di raggrupparsi, per cercare di chiarirsi le idee su quello che avveniva intorno a loro e scoprire le cause immediate e remote di quella crisi. Da questa sete di chiarezza e di nuove intese tra gente ragionevole fuori dai quadri dei vecchi partiti (dalla quale poco dopo sorsero movimenti politici come l’Italia Libera o come l’Unione Nazionale intorno a Giovanni Amendola) ebbe origine a Firenze il Circolo di Cultura. Questo sorse da principio, per generazione spontanea, senza uno statuto e senza un preciso programma, per iniziativa di un gruppo di una ventina di amici, professionisti e studenti, che cominciarono nel dicembre 1920 a ritrovarsi settimanalmente nello studio di uno di loro, l’avvocato Alfredo Niccoli, in via degli Alfani, per discutere, senza intenti di proselitismo, su argomenti politici economici e sociali di interesse attuale.
Alfredo Niccoli era figlio di madre inglese, ed era stato lui a suggerire l’adozione dei metodi di discussione dialogata, comunemente seguiti in Inghilterra nei circoli di cultura politica: in ogni riunione uno degli intervenuti, che una settimana prima si era impegnato a studiare un determinato argomento, svolgeva una breve relazione introduttiva, che aveva soprattutto lo scopo di dare su di esso informazioni precise ed oneste, e di porre in termini chiari il problema: sul quale poi la discussione, o meglio la conversazione, si svolgeva animata fino alle più tarde ore notturne. Regola delle nostre discussioni era che non si veniva mai ad un voto: la previsione del voto mette fino da principio limiti alla discussione; invece, quando non c’è voto finale, si discute solamente per chiarire le idee proprie ed altrui.
Intanto il fascismo, colla marcia su Roma, si era impadronito del potere: e subito dopo, nel febbraio del 192 3, poiché i frequentatori delle nostre riunioni erano diventati così numerosi da non entrar più nello studio Niccoli, fu deciso di trasformare il nostro gruppo in una associazione regolarmente costituita e dotata di propria sede: per raccogliere adesioni e fondi si diffuse una circolare a stampa, che nella sua parte essenziale era cosi motivata:
Viene da molti lamentata la mancanza nella nostra città di un centro di studi che, pur non tralasciando volutamente alcuno dei rami della attività intellettuale, sia orientato in special modo a quelli sociologici nel più largo senso della parola. E’ d’altronde universalmente ammessa l’incultura economica e sociale della cosiddetta classe colta italiana che troppo spesso sulla base di interessate e frammentarie informazioni giornalistiche ritiene di potersi fare un concetto dei complessi fenomeni contemporanei.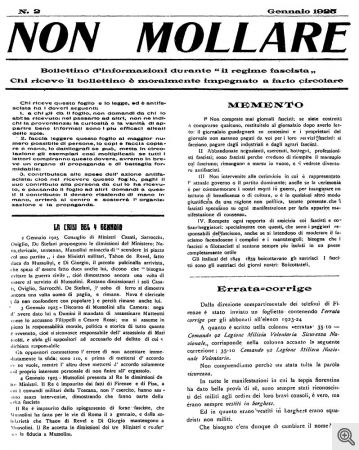
L’attività del Circolo si svolse indisturbata fino alla fine del 1924: può essere utile ricordare qui, per dare un’idea dell’importanza dei temi trattati e della serietà dei relatori, il programma svolto in questo periodo. Dall’aprile al giugno del 1923 le relazioni e discussioni trattarono i seguenti argomenti:
L’idea liberale (relatori Finzi, Salvemini, Burresi); La Germania nel dopoguerra (rel. Marano); L’Italia è un popolo o una popolazione? (rel. Coletti); Il partito popolare italiano (rel. G. Ferrero); Sindacalismo e rappresentanza politica (rel. C. Rosselli); La questione doganale (rel. Rossi); La posizione degli intellettuali nel dopoguerra (rel. Rho); La riforma della scuola media (rel. Pasquali, Limentani); Il materialismo storico (rel. R. Mondolfo); Il problema dell 'emigrazione (rel. Valensin); Il partito laburista (rel. Tawney); Il problema sessuale in Proud/Jon (rel. P. Jahier); La Germania e il problema delle riparazioni (rel. R. Dalla Volta); Le possibilità dell’agricoltura italiana (rel. A. Serpieri); L’industria del cotone (rel. Pontecorvo).
Parallelamente si organizzeranno riunioni e discussioni tra i soci, che dovranno avere carattere di scambi di idee su piede di assoluta eguaglianza; si promuoveranno conferenze periodiche su argomenti di attualità, si addiverrà gradualmente alla costituzione di una biblioteca coll’acquisto delle novità più significative.
C
Non è il caso di diffonderci ulteriormente sul programma. Più che il programma confidiamo che varranno le opere. Non abbiamo di mira scopi grandiosi; non ci riproponiamo di “rinnovare”, di “riformare”, di dar vita a “nuove correnti”. Tanto meglio se i timidi semi fruttificheranno.
La circolare era firmata da un Comitato promotore, cosi costituito:
professor Piero Calamandrei, professor Gino Frontali, Piero Jahier, professor Ludovico Limentani, professor Mario Marsili Libelli, avvocato Alfredo Niccoli, dottor Carlo Rosselli, dottor Ernesto Rossi, professor Arrigo Serpieri, dottor Aldo Sorani. Nessuno di questi uomini era, in quel momento, iscritto ad un partito; nessuno di essi, negli anni successivi, diventò fascista, salvo il Serpieri.
Già prima di diramare questa circolare, ci eravamo assicurati un locale adatto, al primo piano di un palazzo quattrocentesco al numero 27 di Borgo Santi Apostoli, sull’ango1o di piazza Santa Trinità, di proprietà di un amico, il signor Vincenzo Howells, che ce lo aveva ceduto in affitto per un canone di favore; la grande sala, le cui finestre davano sulla piazza, proprio di fronte alla colonna della statua della Giustizia, fu arredata senza molta spesa, con mobili offerti da soci volenterosi: tavolini, seggiole e scaffali furono donati dai Rosselli, la stufa dall’avvocato Celasco. Si comincio a metter su, con libri offerti dai soci, una piccola biblioteca di scienze politiche: alcuni mandavano al Circolo, in seconda lettura, le riviste a cui erano abbonati; le riviste straniere furono quasi tutte fornite dai Rosselli.
Il Circolo si costituì con una cinquantina di soci, che, dopo approvato lo statuto, nominarono il Comitato direttivo, composto delle stesse persone che avevano fatto parte di quello promotore,

