Eugenio Scalfari, La sera andavamo in Via Veneto, Gedi 2022
...
XI - La solitudine di Berlinguer
In quella direzione noi spingevamo da sempre. Ugo La Malfa era stato antesignano della politica del rigore come condizione dello sviluppo e fin dalla famosa “nota aggiuntiva” redatta da ministro del Bilancio e della Programmazione nel 1962 ne aveva indicato le direttrici. Rigore e sviluppo, moderazione salariale e pieno impiego, risanamento dei conti dello Stato e riscatto del Mezzogiomo, erano stati i capisaldi del programma liberal-democratico per vent’anni: purtroppo attuati in minima parte e poi completamente travolti sotto l’alluvione clientelare e assistenziale degli anni Settanta-Ottanta.
Nel ’77, mentre la crisi economica e il tasso d’inflazione avevano toccato uno dei punti di culmine, Luciano Lama dette un’intervista a Repubblica che segnò una svolta nel movimento sindacale. L’intervista era maturata dopo parecchi incontri che avevo avuto con lui e lunghe discussioni serali durante le quali ci eravamo parlati come si discute tra vecchi amici, senza prudenze né diplomazie. Sicché quando Luciano Lama infine m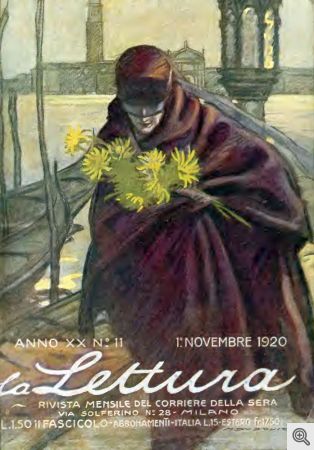
Lo sapevo, ma non l’immaginavo neppur io così radicalmente autocritico e nuovo rispetto alla politica fin lì seguita dal movimento sindacale. Parlò per oltre un’ora senza bisogno né di domande né di sollecitazioni. Uno dopo l’altro mise in discussione tutti gli elementi sui quali il sindacato aveva costruito la sua strategia a partire dal famoso “autunno caldo” del ’69, a cominciare dal “salario come variabile indipendente” e dalla rigidità nell’uso della forza-lavoro. Rivendicò però con orgoglio la battaglia che il movimento aveva vinto per la conquista dei diritti civili nelle fabbriche contro l’oscurantismo del patronato e ricordo che senza il contributo della classe operaia e delle sue rappresentanze politiche e sindacali non era pensabile consolidare la democrazia italiana. Concluse indicando una piattaforma di austerità salariale, di mobilità dei lavoratori e di revisione dello Stato sociale come premesse necessarie per risolvere le due grandi questioni d’Italia: il Mezzogiorno e la disoccupazione.
Fece molta sensazione, quell’intervista, sopratutto nelle grandi fabbriche perché la “base” – o meglio i quadri intermedi del sindacato che venivano tutti dall’esperienza dei Consigli di fabbrica - non si aspettavano un’inversione di rotta cosi brusca e non erano preparati ad accettarla. Seppi che in molti luoghi di lavoro gli operai pensarono che l’intervistatore avesse fatto dire a Lama cose che egli non pensava: o cosi gli fu fatto credere dai quadri del sindacato. Ma Lama, molto lealmente, s’incaricò di smentire personalmente quelle dicerie e rivendicò l’autenticità del suo pensiero.
Accoglienza altrettanto fredda ci fu nel Pci, sebbene proprio nello stesso arco di tempo Berlinguer avesse lanciato anche lui il tema dell’austerità come piattaforma ufficiale del partito. Ma la sua era un’austerità di tipo alquanto diverso da quella di Lama e partiva dalla questione morale più che da un’analisi attenta delle strutture economiche.
Giorgione - come lo chiamavano affettuosamente nel partito - aveva molti rimproveri da muovere al sindacato, ma sopratutto al suo Pci, che avrebbe voluto molto più libero e autocritico all’interno e assai più rigoroso nei confronti del “sindacalese”. Aveva fretta di novità, Giorgio Amendola, temeva che il tempo mancasse, che il ritardo per la sinistra operaia diventasse incolmabile. E lo diceva, instancabilmente, nei comizi, negli articoli, nelle interviste, in direzione, agli amici.
Lama, Berlinguer, Amendola, tra il ’77 e il ’79, portarono avanti da posizioni diverse ma certo non contrapposte un tema essenziale: quello d’una classe operaia che assume su di sé i sacrifici necessari per rimettere in corsa lo sviluppo inceppato e che rivendica, in forza di quei sacrifici, un ruolo di direzione politica e di “egemonia”. Ma quel discorso non fu capito né dentro né fuori dal Pci.
Fuori, i possibili interlocutori politici e imprenditoriali fecero i sordi, con qualche rara eccezione, tra le quali merita di essere segnalata quella di Carlo De Benedetti. Dentro al partito il dibattito sconfinò presto verso i “massimi sistemi”, mentre il gruppo dirigente si arenava giorno dopo giorno nelle sabbie mobili andreottiane dei tatticismi e dei compromessi parlamentari.
Ad indicare una via chiara, un ruolo costruttivo e una sponda cui approdare per una nuova politica di alleanze democratiche, rimasero La Malfa e il gruppo liberal-democratico del quale noi eravamo l’espressione più esplicita. Ma era poco per stimolare efficacemente il Pci ad uscire da mezzo il guado.
Poi vennero meno a breve distanza l’uno dall’altro sia La Malfa che Amendola e tutto diventò ancor più difficile.
Le elezioni politiche del ‘79 furono per il Pci un risveglio penosissimo, ma forse, a giudicare oggi, i risultati furono meno gravi di quanto la crisi d’identità del partito facesse presumere. La conversione repentina di Berlinguer dal compromesso storico all’alternativa servì probabilmente a salvare il grosso della forza elettorale e a rinviare ancora di qualche anno l’ora della resa dei conti del Pci con se stesso; ma l’esercito comunista era ormai in ritirata e la sola preoccupazione del suo leader era di non trasformare quella ritirata in una rotta disordinata.
Incontrai Berlinguer per due volte nelle settimane che seguirono alle elezioni, una sera in casa di Tatò e, pochi giorni dopo, in casa mia. E fui colpito sopratutto dalla solitudine politica di quell’uomo. Forse per responsabilità sua o perché tra lui e gli altri dirigenti del partito s’erano creati diaframmii psicologici o perché la sua solitudine non era una questione individuale ma rifletteva una situazione politica di tutto il Pci: non so dire, ma sta di fatto che ebbi la sensazione fisica d’aver dinanzi non già il potente segretario del maggior partito comunista d’Occidente, temuto fuori e adorato dentro la sua fortezza, bensì un uomo che vede lucidamente allontanarsi la riva sulla quale aveva sperato di poter sbarcare in forze e a bandiere spiegate con tutta la sua gente, vede la corrente rinforzarsi e portarlo lontano, verso terre ignote e comunque non visibili e non segnate sulle carte della sua geografia.
Era abbastanza disperato il Berlinguer che vidi in quei giorni. Ma anche molto determinato su ciò che ora doveva fare. Nel primo incontro aveva con sé un appunto sulle perdite elettorali subite dal partito e me lo mostrò. - Vedi, mi disse, abbiamo perduto nei quartieri operai e popolari delle grandi città, non in quelli borghesi. Quella parte di ceto medio che ci era venuta incontro è rimasta con noi, ma sono gli operai che ci hanno punito. Dobbiamo capire perché e dobbiamo recuperare quei voti. Ogni altro discorso ora viene dopo -. E mi indicava i magri risultati dei comuni torinesi di cintura, delle borgate romane, di Sesto San Giovanni, delle periferie industriali di tutt’Italia.
- E. per che cosa, allora? - gli chiesi, per fare la rivoluzione? Enrico, tu ci credi ancora alla rivoluzione?
Seguì una lunga conversazione, di quelle che significano tante cose e nulla affatto. Lui diceva che sì, la rivoluzione era tutta da fare e bisognava farla. Ma quale, domandavo io. E lui tornava sulla questione morale e sulle istituzioni occupate e inquinate dalle lobbies, sulla democrazia bloccata, sui comunisti relegati nel ghetto della discriminazione, sulla loro orgogliosa e insopprimibile “diversità”, ultima speranza di risanamento d’una democrazia debole e manovrata dai poteri paralleli e dai contropoteri criminali, a cominciare da mafia e camorra. - Non è una rivoluzione, questa? - mi disse con quei suoi occhi dolci e tristi, disegnati all’ingiù come quelli d’un Pierrot.
In verità vagheggiava ancora d’una classe operaia che, come la descriveva, non c’era più, ammesso che ci fosse mai stata, La sua gente non somigliava al ritratto che ne faceva, anche se probabilmente sentiva quelle urgenze in modo più acuto di altri gruppi sociali e di altre aggregazioni politiche. Lui era sicutamente un “diverso” dall’Italiano di Alberto Sordi. Un “diverso” che ispirava una grande simpatia, un grande rispetto - almeno a me – ma a quel punto sicuramente un perdente proprio in ragione della sua diversità cui non voleva, non poteva e non sapeva rinunciare.
Enrico Berlinguer ha fatto compiere al Pci molti e importanti passi avanti verso il rinnovamento, ma su un punto non ha ceduto neppure un pollice di terreno: quello della “diversità” come un bene in sé in un mondo di furbi e d’ipocriti. Non so dire se, da un punto di vista politico, sia stato un bene o un male inchiodare il Pci alla sua diversità, come lui l’ha certamente inchiodato. Sicuramente è stata una battaglia di retroguardia che lo ha visto sempre più solo e - per quanto mi pare d’avere capito - sempre più disperato. Sicché non poteva che morire come è morto, arringando la sua gente e regalando al partito, in uno sforzo estremo, un paio di punti in percentuale per il solo fatto d'esser morto in quel modo.
Era naturale che fosse Sandro Pertini ad andar a prendere quella salma. E chi ci doveva andare se non il vecchio Presidente, così lontano dalle introversioni e dalle timidezze berlingueriane, ma anche lui così diverso da quegli stessi italiani che per sette anni ne hanno fatto un simbolo benemerito?
Ed era altrettanto naturale che mentre declinava il Berlinguer superstar che aveva dominato il firmamento politico tra il ‘73 e il ’76, sorgesse all’orizzonte la stella di Bettino Craxi. Con quella nuova stella noi abbiamo dovuto fare i conti, e sono stati conti molto difficili.
2022 - Enrico Berlinguer
powered by social2s

