
Bisogna chiedersi, allora, cosa abbia voluto dire il nostro carissimo e fraterno amico Gabriele Tardio col suo prezioso libretto sulla storia delle bande musicali di S. Marco in Lamis.
Nel sec. XVII nella nostra cittadina non abbondava la ricchezza. Una Relatio ad limina del Card. Domenico Ginnasio, arcivescovo di Manfredonia, scritta negli ultimi anni del '500 presenta un quadro desolante di S. Marco e del convento di S. Matteo. Si dice che a S. Matteo i Frati erano pauperrimi, e di S. Marco si dice che avesse meno di cento fuochi, e che nella sua chiesa non si poteva dire neppure una Messa al giorno per mancanza di mezzi necessari.
Questo quadro desolante cambia radicalmente nel '600. Vediamo, Nel convento di S. Matteo si pose mano a un poderoso programma edilizio che trasformò interamente il convento. Nel contempo a San Marco si sviluppò l'amore per la buona musica, una tendenza artistica gratuita e onerosa non finalizzata ad alcun tipo di lucro.
Non sono un esperto di storia sammarchese, credo però che fra il convento e la cittadina si sia innescato un flusso virtuoso di energia fatto di rinnovato interesse per la vita creativa e produttiva.
A San Marco è successo qualcosa di simile soprattutto nelle classi urbane, non legate direttamente alla terra, la cui capacità di guadagnarsi il vivere quotidiano era affidato esclusivamente a una manualità intelligente e creativa.
Sappiamo, del resto, che cosa abbia rappresentato nella storia di San Marco l'insieme degli artigiani. All'interno di questo gruppo si è sviluppato sia l'amore per la musica che la molteplicità delle tecniche e delle espressioni musicali. Si aggiunga, poi, che la maggior parte dei musicisti impegnati nella musica attiva, anche nella normale vita lavorativa erano degli artisti raffinati capaci di produrre autentici capolavori. Si pensi agli orafi, ai falegnami, ai sarti. Ben pochi di loro sono morti ricchi. Tutti erano orgogliosi della precisione dei loro manufatti, del perfetto rapporto armonico tra le varie parti, della bellezza dell'ornamentazione. Si può dire che il frutto del loro lavoro, prima di essere il necessario mezzo della sopravvivenza, era il soggetto bello di una gratuita contemplazione.
A partire da questo gruppo la musica a S. Marco diventa un luogo dove la popolazione si ritrova e costituisce, di conseguenza, un importante dato identitario della nostra comunità. Il libretto del compianto Gabriele Tardio, La banda musicale a San Marco tra Sei e Ottocento, ha il merito di mettere in luce come il gusto della musica sia un retaggio ancestrale, un importante elemento che ha accompagnato, e tuttora accompagna lo sviluppo civile, economico e culturale del popolo sammarchese dal seicento, da quando cioè la cittadina era poco più di un villaggio, fino alla fine dell'Ottocento, quando S. Marco era una città di oltre 16.000 abitanti.
Una delle importanti funzioni formative della musica attiva è costituita dalla disciplina della voce, del tempo e del gesto. Far musica è anche stabilire un rapporto dialogico con gli altri con cui s'impara la difficile arte dello stare insieme superando timidezze e individualismi. Favorisce, quindi, l'integrazione armonica, la collaborazione e il reciproco completamento. Favorisce, poi, in modo determinante la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità.
Tutti gli aspetti della vita cittadina, dalle feste religiose e civili, dalle espressioni amicali a quelle strettamente personali e gratuite sono stati vissuti a San Marco attraverso una forte presenza della musica nella sua dimensione più diffusa e popolare.
Così gli artigiani non si dedicavano solo alla nobile pratica della banda, ma si concedevano momenti di puro diletto, amicale e familiare. Tutti ricordiamo il lunedì di San Crispino consacrato da ogni buon artigiano al riposo, alla famiglia e agli amici. San Crispino era un calzolaio a cui tutti gli artisti del cuoio erano devoti. Ma anche chi non trafficava con pelli, aveva i suoi vantaggi dalla protezione del santo. Spesso, quando il tempo permetteva, gli amici, armati dei loro amati strumenti, salivano al Villaggio per il meeting settimanale a base di pane, formaggio e muscisca. Al vino ci pensava Pietro Villani, titolare dello storico bar, erede di una delle prime case costruite nel 1908 quando il borgo nacque con nome di Villaggio S. Matteo, tenuto a battesimo dal P. Guardiano di S. Matteo che benedisse la prima pietra. Il ritorno della comitiva costituiva uno straordinario momento di incanto. La musica che il complessino itinerante ci regalava si fondeva col quieto stormire del boschetto e i radi squittii degli animali notturni; risuonava all'interno della valle con un sistema di rimandi ed echi. I suoni perfettamente fusi e pur distinti nelle loro particolarità timbriche, costruivano un'armonia di difficile definizione che ti riappacificava con le asperità della vita e ti delineava un quadro di altissima contemplazione in cui tutto pareva al suo posto. Noi giovani frati eravamo incantati da tanta grazia offertaci da tanta generosa intelligenza.
Per quanto attiene le celebrazioni liturgiche la musica non era mai generica, costituita, tanto per intenderci, da quei brani buoni per tutte le occasioni, tanto care agli strimpellatori ancora di moda in alcune chiese. I canti erano scelti in stretto rapporto con le celebrazioni. Il fluire dell'anno liturgico era il canovaccio obbligato di ogni organista: Natale, l'avvento e la quaresima, i santi, la Madonna, ecc.
Una cura particolare era riservata all'Ufficio delle tenebre, vale a dire ai salmi, ai responsori e alle letture del giovedì, venerdì e sabato della settimana santa. L'ufficio di queste giornate, tutto in musica, in altri luoghi più fortunati era cantato con musiche di Palestrina, Allegri, Durante, Traetta ecc. La settimana santa era uno straordinario momento religioso, ma anche un complesso fortemente articolato di musiche di altissimo livello. Qui a S. Marco, come sempre, si faceva quel che si poteva, ma rievocando antichissime melodie ereditate dalle profondità della storia e tutte ruotanti intorno al ceppo intramontabile del canto gregoriano.
A San Marco, come del resto in tanti altri posti, il gregoriano era proposto in una serie di molteplici interpretazioni locali attraverso cui s'intravvedeva il ceppo originario. Il modo di cantare era tipico di una società che praticava modelli antichissimi di grande dignità, ma attraverso una tradizione contadina che tendeva a dialettizzare ogni espressione, per quanto nobile fosse. Anche il nome dell'Ufficio delle Tenebre, così si chiamava l'Ufficio della Settimana Santa, ebbe l'onore di una reinterpretazione coniata nell'angiporto di S. Antonio Abate o in qualche bottega della Padula: Li frufficicchie. Cosa significasse il nuovo nome, e che ruolo avessero nella faccenda le forbicine delle sarte, nessuno saprà mai.
|
|
| Da una cartolina sonora di Giuseppe Bonfitto del 1970. In questo filmato puoi vedere anche le cosidette 'frufficicchie' |

Le varie devozioni ci offrono un quadro musicale altrettanto nobile e variegato. Le devozioni, si sa, appartengono all'animo religioso più concreto e terrestre della popolazione. Attraverso le devozioni la gente santifica tutto il vivere, dalla famiglia al lavoro, al morire. Le chiese, popolate di confraternite, erano anche scrigni di cose preziose che emergevano lungo tutto il corso dell'anno suscitando aspettative e coinvolgendo sentimenti: Natale, il settenario dell'Addolorata, san Michele, san Nazario ecc.
I custodi di questi tesori erano gli organisti delle varie chiese. Addestratisi con l'antica pratica dell'andare a bottega, avevano rubato a chi li aveva preceduti i rudimenti dell'arte della musica, i modi gregoriani, le tonalità moderne, avevano imparato ad operare modulazioni, trasporti ecc. Erano, inoltre attentissimi alle variazioni di gusto e alle nuove tendenze musicali. Non facevano, poi, gran caso alle differenze fra musica liturgica e musica operistica. Così gli intervalli si popolavano di fantasmi pucciniani, di ricordi delle romanze di Francesco Paolo Tosti, a volte di poderosi quadri verdiani.
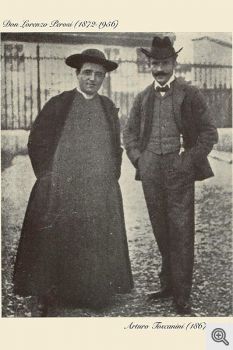
Il canto, poi, era qualcosa di grandemente apprezzato dalle ragazze da marito. Sorpresi, una volta, alcune comari che, filando la lana e rattoppando i pantaloni dei mariti, sedute all'aperto, parlavano di un giovane aspirante sposo di una ragazza: sci, è nu bell guagliole, ma non sape cantà.
Le case, poi, erano spesso ornate di bellissime stampe che raffiguravano scene opere più popolari: La Boheme, la Cavalleria Rusticana. Anche i miei nonni avevano due quadri che raffiguravano scene della Carmen di Bizet.
Oggi S. Marco, anche se mortificata, conserva l'antico fuoco della musica come un dono di natura. Non devo enumerare i gruppi e le associazioni che operano in questo campo con lungimiranza e spirito di servizio. Voglio solo sperare che questo nascosto tesoro venga maggiormente a galla per aiutare a riacquistare fiducia e speranza.
P. Mario Villani
Convento S. Matteo, 2 settembre 2013

