www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/D_Arzo/4_Costanzi.html del 03 febbraio 2022
Nostro lunedì di Ignoto del XX secolo: il vortice e il vertice della narrativa di SilvioD’Arzo
di Stefano Costanzi
Il lungo metraggio darziano: la costruzione di un romanzo
Silvio D’Arzo nella sua ultima lettera a Vallecchi del 26 settembre 1951, a seguito del rifiuto di Casa d’altri da parte dell’editore e amico fiorentino, a ormai pochi mesi dalla morte, scrive quello che a posteriori si legge come un addio ma che è soprattutto un programma di lavoro:
“[...] fammi un favore: mandami il manoscritto di Casa d’altri: ma presto: ne ho urgentissimo bisogno. Te ne sarei riconoscentissimo. Scusami. Quanto al lavoro, lavoro: non faccio altro: ma sono appena uscito dalla clinica, e adesso debbo andare molto adagio. [...] Tante cose, caro Vallecchi, ed una stretta di mano. A suo tempo mi farò vivo con 500 pagine”.

Ma Silvio D’Arzo, lo scrittore che a discapito dei fatti della cronaca ha da sempre abbracciato la lezione jamesiana “fatta, anzi, più di reticenze che parole, più d’allusioni che affermazioni”, trova nella struttura del romanzo progettato il punto di unione tra tensione narrativa e stilistica: per il narratore reggiano il giusto indirizzo tra via della Cronaca e via dell’Arcadia, ovvero tra realismo e tensione lirica, è Nostro lunedì di Ignoto del XX secolo. Infatti egli pensa a un romanzo costruito su racconti già nella primavera del 1947; la corrispondenza testimonia come il disegno di una narrazione alla Lermontov, sul modello di Un eroe del nostro tempo, acquisisca tratti più definiti sino agli ultimi giorni di vita di Ezio Comparoni.
Sono state le sapienti cure e le acutissime intuizioni di Anna Luce Lenzi (1986) a ricuperare il cardo e costruire il decumano di una città sepolta di cui si riteneva di possedere la sola planimetria: la Prefazione a Nostro lunedì uscita nel 1960 nel volume curato da Macchioni Jodi per Vallecchi, Nostro lunedì. Racconti, poesie, saggi, prima raccolta delle opere darziane. Il testo intende introdurre la narrazione di vicende accadute in sei anni, dal 1942 al 1948, a un gruppo di giovani e velleitari letterati e, attraverso una prospettiva multipla di punti di vista, ricostruire il loro percorso di formazione alla vita adulta, sino a farla diventare dato universale, quel lunedì che è appunto Nostro. La studiosa, intrecciando i dati di cui disponeva e lavorando su piccoli indizi, ha segnato il sedime urbanistico di un romanzo a più chiavi,costruito su più racconti e su molteplici focalizzazioni, il cui vortice e vertice avrebbe attratto tutta la precedente produzione dello scrittore reggiano: una Eneide del Novecento che mirava a esprimere, come dice a Vallecchi il 17 dicembre 1949, “quel comune denominatore in cui tutti noi, a qualsiasi fede o idea apparteniamo, ci riconosciamo”. Un riconoscersi a partire dal nome stesso dell’autore che, a differenza degli altri eteronomi scelti in precedenza da Ezio Comparoni, non nasconde ma manifesta; se non il dato anagrafico quello di verità: Ignoto del XX secolo per dire chiunque: perché tutti sono stati toccati dalla guerra e tutti con fatica ricostruiscono sé stessi nel faticoso scenario postbellico.
Come il poema classico anche Nostro lunedì di Ignoto del XX secolo consta di un ciclo militare e di uno civile, di una Iliade e di una Odissea; insomma, il tentativo di edificare un’opera mondo in cui l’autore – come ha giustamente sottolineato Alberto Bertoni (2003: XXIV) –
“si sforza di approdare alla forma non forma e al finito non finito di Nostro lunedì, […] una Eneide del XX secolo, che muove dal presupposto di una guerra perduta, raggiunge l’approdo di una casa d’altri lì dovrebbe a provarsi a fondare una nuovaciviltà […]”.
Ritrovamenti e prospettive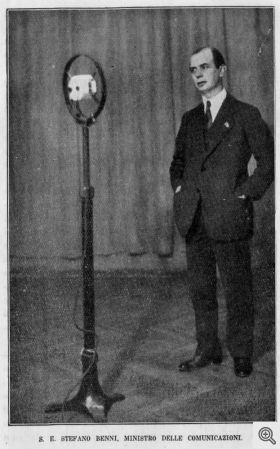
Questi stessi capitoli, proprio per il loro statuto, innalzati su più punti di vista, permettono una certa autonomia di lettura: infatti l’autore pubblica, il 24 febbraio del 1950, Una fasciatura ben fatta su Il secoloXIX, evidente porzione del ciclo militare e in perfetta successione con i testi ritrovati: [Doveva essere cominciato anni prima] e [Naturalmente questo non poteva esser stato]. Per questi infatti, ancorché acefali – sono rispettivamente i capitoli 2 e 3, sebbene interrotti, e manca il finale del primo testo –, è evidente la continuità per personaggi, temi e vicende narrate con il resto del ciclo militare. 
In ordine alla logica del romanzo, ben illustrata dall’Ignoto nella Prefazione, Tutta colpa di quella domenica, per quanto da un canto mantenga una certa indipendenza di lettura, dall’altro è accostabile e complementare al frammento conservato nel Fondo Degani, sempre alla Biblioteca Panizzi, [Erano appena le nove]. Il secondo prisma della prospettiva multipla tramite cui osserva e narra l’Ignoto – “E ho fatto poi altri tre anni il cronista”, scrive nella Prefazione – è una redazione di provincia in cui, attraverso il coro dei redattori, si raccontano gli eventi, che devono essere però ricomposti dal lettore avvertito che sotto l’epidermide di un parlamento buffo, in bocca ad un narratore ingenuo, sotto – o sopra – ai fatti c’è l’umanità, e se ci si avventura oltre, nel terreno sconnesso dei frammenti, tenendo le postille e le lettere a mo’ di bussola, anche una storia d’amore.
Se l’orologio interno alle narrazioni del Comparoni non fosse rotto e se la contabilità degli anni fosse per D’Arzo-Ignoto una rigorosa disciplina, si potrebbe tranquillamente pensare che il capitolo [S’era alzata un po’ di nebbia] sia tra le ultime tessere di Nostro lunedì di Ignoto del XX secolo, se non del racconto certo della storia, se non dell’intreccio certo della fabula: la vicenda è narrata otto anni dopo l’inizio degli accadimenti del romanzo. Il testo è tra i quattro ritrovati quello maggiormente svincolato dai frammenti rinvenuti sino a ora e per quello che è dato sapere potrebbe essere anche la motrice dell’intero romanzo, vero però è che piccole e deboli spie testuali testimonierebbero diversamente, tanti sono i riferimenti dati per scontati a un lettore che deve già conoscere, a esempio e sopra tutti, il Probabile Arboreo, il direttore del giornale. Questo capitolo è quello però più intimamente unito alla Prefazione. Tratta del misurare attraverso un nostos, un ritorno in Arcadia da parte del personaggio magro, le distanze da quel gruppo di amici letterati il cui narcisismo è amaramente irriso nella Prefazione:
“La letteratura è il più complicato dei mali; non c’è cura che valga per lei: e i giovani letterati alle volte le più offensive creature del mondo”.

Per quanto i quattro testi ritrovati – autografi in bella copia in una grafia ordinata e leggibile e quindi in una fase abbastanza avanzata secondo l’usus operandi dell’autore – siano in continuità stilistica e strutturale con il progettato romanzo, numerose sono le peculiarità e originalità di questi quattro racconti-capitoli di cui gli studi futuri dovranno tenere conto: dalla mimesi del parlato portata all’estremo, giocata sull’ellissi, sul non detto e non solo sul magistero di Hemingway o Faulkner – in una postilla delle carte ritrovate si legge che il libro non deve correre il “rischio di essere troppo americano” –, agli affondi alla politica dello scenario postbellico, ma sempre e solo in una funzione di coerenza coll’opera, parimenti lontani dalle leziosità dell’Arcadia quanto dalla materialità della Cronaca.
Riproposizioni e spostamenti
Ciò che sorprende in maggior misura e che abbozza i sentieri delle future ricerche darziane, con l’auspicio che nella messe copiosa di carte ritrovate emergano nuovi testi della galassia Nostro lunedì, sono le riprese non solo di stilemi, giri di frase e iterazioni anaforiche che il Comparoni più maturo in una sorta di autocitazione dissemina nei suoi scritti narrativi (non tanto segno di una inerzia espressiva piuttosto di un entusiasmo per risultati raggiunti figli della tendenza mai sopita di colorare di realtà personaggi al di là dei postulati neorealistici), ma il ripresentarsi di tematiche in una sorta di spostamento, di Verstellung freudiano. Come non leggere ancora una volta, già in Essi pensano ad altro, lo scontro tra l’idealismo ingenuo dell’allievo ufficiale, il letterato puro, e il crudo realismo del capitano medico? O l’eco della domanda di Zelinda nella lettera che Riccardo, uno dei personaggi focali del ciclo militare, legge sul carro postale destinato ai campi di prigionia del nord, su cui coi compagni aspetta la notte per fuggire:
Anche Riccardo allungò allora una mano nel mucchio. Ne prese una senza guardare, e l'aprì.
“Carissimo Paolo,
eccoti intanto duecento lire. Mi hanno insegnato una cosa. Non ho fatto un'assicurata perché quelli (hai capito?) sono magari capaci di mangiare la foglia e non ti danno niente e se la tengono loro. Così, meglio essere sicuro. Capisco anch'io. Come no? Io ti capisco benissimo. Solo che per adesso bisogna avere pazienza. Tutto il segreto sta lì: avere pazienza. E tu poi, per favore, non dirmi più quello che mi hai detto nell'ultima tua. Come fai a dire una cosa così? Lo so bene che vengono delle idee, certe volte. Io ti capisco benissimo. Tu non vuoi che io ti parli di Chiesa: e va a bene: non parlo: ti ho forse parlato di Chiesa? Solo ti dico: non dire più una cosa così, fa il piacere. Come si fa, alla tua età? E allora, io? Ne ho sessantuno a febbraio, lo sai? Spero che questa lettera riesca a tenerti un po' su, e così anch'io …”

Bibliografia
Le citazioni sono tratte da Silvio D’Arzo, Opere, a cura di S. Costanzi, E. Orlandini, A. Sebastiani, Parma,Monte Università Parma, 2003; e da Id., Lettere, a cura di A. Sebastiani, Parma, Monte UniversitàParma, 2004.
Bertoni A. (2003), Verso l’opera mondo: per un’introduzione a D’Arzo, in Silvio D’Arzo, Opere, a cura diS. Costanzi, E. Orlandini, A. Sebastiani, Parma, Monte Università Parma, pp. VII-XXIV
D’Arzo S. (1960), Nostro lunedì. Racconti, poesie, saggi, a cura di R. Macchioni Jodi, Vallecchi, Firenze
Lenzi A. L. (1986), Introduzione, in Silvio D’Arzo, Nostro Lunedì di Ignoto del XX secolo, a cura di A. L.Lenzi, Modena, Mucchi ed., 1986, pp. 13-37
Montale E. (1954, March 10). Letture. Silvio D’Arzo. Corriere della sera, p. 3
Raimondi E. (2004), Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo, in Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo. Atti della Giornata di studi, Reggio Emilia, 13 aprile 2002, Reggio Emilia, Aliberti, pp. 13-21.

