Epoca, n. 0001 del 14 ottobre 1950
G. A. Borgese e il Governo Mondiale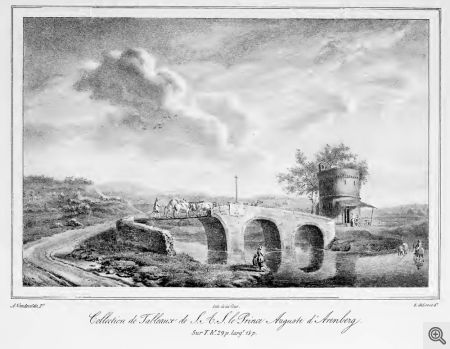
Vorrei saperne qualche cosa da Borgese, che stimo molto; e vorrei sapere se egli ci crede. (Elena T, maestra 25enne, Abbiategrasso)
Si, si credo. E lei lo vedrà.
O alzato da noi su basi di giustizia o calcato su noi dal tallone della forza.
Appartengo alla nuova generazione, ho sempre sentito dire che Borgese è stato un grande professore di estetica, il quale ha scelto la via dell’esilio durante il passato regime.
Vorrei conoscerne le ragioni. (Marco Rubini, classe 1929, Macerata)
“Anche l’arte", - e perciò anche l’estetica che è l’intendimento dell’arte - "vuole una patria"; così disse un poeta di tempi migliori; e non è patria se non fisica quella della libertà, che è responsabilità, del pensiero e dell’arte è soggiogata al potere di un solo. Mi staccai fisicamente dall’Italia d'allora per restare fedele all’Italia di sempre.
Ho letto molti anni fa un articolo di Borgese su Piovene, che credo fosse il primo articolo di un critico illustre sull'allora giovanissimo scrittore vicentino. Cosa pensa oggi Borgese dello stesso Piovene. (Giulia S., lettrice accanita, Forlimpopoli)
Può essere che quella mia colonna sia stata la prima presentazione del Piovene, scrittore allora giovanissimo (da due anni laureato a Milano, nella mia scuola d’Estetica di cui fu eminente scolaro). E fu, quell’articolo, se la memoria non m’inganna, l’ultimo di critica letteraria italiana che io scrivessi prima di partire; altri non mandai di lontano; e ce ne volle prima che quelle furono pubblicate, il mio giovane amico non essendo in odore di santità. Ma del Piovene di dopo il ’31 non conosco ch saggi e articoli, tutti ricchi e coloriti, anche quando non consento alle sue opinioni politiche. Dei libri e racconti che gli hanno procurato fama tra le maggiori nella nuova generazione non so dir nulla. Me li ha promessi tutte le volte nei vari luoghi, Parigi, Firenze, Berlino, dove ci siamo incontrati dal ‘48; forse perché, com’egli dice con altre parole, il giardiniere che bada a nuovi fiori non si cura più molto delle roses d’antan.
Desidererei chiedere al prof. Borgese se sia vero ch'egli riprenderà la critica letteraria del Corriere della Sera; e inoltre quali siano oggi i suoi interessi letterari più vivi. (Yvette Marchesi, studentessa ventenne, Milano)
Ho ricominciato a scrivere per il Corriere, ma non riprendo la critica letteraria, di cui d’altronde non vi esercitai mai monopolio. Qualche articolo, soprattutto di rivalutazioni e neo-interpretazioni, potrà non dispiacere ai lettori mentre gioverà a me per dissipare via via l’ignoranza in cui m’avvolge quanto alla letteratura di dopo il ’31. I miei interessi letterari più vivi sono oggi politici e, come spinozisticamente si direbbe, teologico-politici. Tali furono, se è permesso riferirmi per orientamento a esempi così fuor di misura, quelli di Dante quando scriveva la Monarchia (e anche quando scriveva la Commedia), e di Milton, tanto in Areopagitica quanto nel Paradiso Perduto e in Sansone.
Il libro a cui lavoro ora, e che Piovene ha promesso di tradurre dall’inglese in cui lo cominciai e in cui lo continuo, s’intitola Fondamenti della Repubblica Universale. Quello che segue s’intitola, per ora, Hagia Sofia, che verrebbe essere un discorso e preghiera alla Santa Sapienza. Del terzo so il tema, ma è presto ancora per dirne il nome. Se avrò anni e forza di scrivere anche il terzo, satis erit. Il titolo complessivo dei tre è Sintassi.
Ciò suona ambizioso. Ma non è. Disse Mattew Arnold:
“Se hai una sola vita, agganciala a una stella".
Non intendeva dire che quella debole vita e la stella sono la stessa cosa.
Intanto Mondadori va ripubblicando le mie opere che il fascismo e la guerra resero tutte irreperibili.
Sono tutte novità per la generazione venuta alla luce dopo il ’30.
L’attuale crisi della critica militante, di cui Borgese fu uno degli esponenti maggiori, è dovuta ad una crisi interna della critica stessa, o a una decisa stanchezza da parte del pubblico, il quale più non la richiede, giustificando così la sparizione dei critici letterari dalle terze pagine dei giornali? (Ottavio S., Roma)
Hmm.
So che Borgese, durante il suo esilio, ha avuto modo di avvicinare il conte Sforza. Che giudizio può dare Borgese del nostro ministro degli esteri? (Prof. G. E., Milano)
Avevo “avvicinato” Sforza molto prima dell'Esilio, fin dal 1917 a Corfù, e ho continuato ad avvicinarlo dopo. Egli ha ora accettato la mia proposta di essere presidente d’onore del Quarto Congresso del Movimento Mondiale per una Federazione Universale (Roma, gennaio ‘51) e di tenervi il discorso inaugurale. Non è necessario essere e essere stato d’accordo con lui su ogni punto e in ogni fase della sua carriera. E’ necessario riconoscere la costanza del suo coraggio e la fermezza del suo ossequio alle idee più alte della tradizione italiana e della coscienza politica universale.
Molti fascisti furono in buona fede. Ma in genere gli uomini non riconoscono la buona fede di coloro che sono anzitutto degli ideologi. Ad esempio, si sostiene che Rosenberg fu un criminale di guerra. Si deve quindi dedurne che tale giudizio spetti anche a Gentile? Che ne pensa Borgese, ammesso che EPOCA riesca a farmi ottenere una risposta proprio da lui? (Giovanni Fantin, Venezia)
La filosofia e la politica di Gentile non furono le mie. Ma non posso rievocare senza commozione l’amico e collega di altri tempi, l’uomo non solo di grande ed eloquente sapere, ma di cuore e carattere, che portò fino agli estremi corollari il pensiero in cui credette e portò se stesso a subirne le conseguenze estreme. Fidem, anche se fu fede errata, firmavit sanguine. Ricordando la sua morte non posso dimenticare di essere figlio di un’epoca nella quale fu possibile a un poeta dire (senza farsi tirar le uova marce) “è la pietà che l'uomo all’uom più deve“; pietà, nel caso presente, anche nel senso maggiore di pietas, riverenza al caduto.
(Rosenberg, coi suoi deliri razzisti, fu tutt’altra cosa, e non so come Le venga in mente di appaiarle a Gentile. Però io non faccio il tirapiedi al boia, neanche a quello di Norimberga).
Borgese ara presente fra noi, il 12 giugno scorso, alla proclamazione dal vincitore del premio dl poesia S. Babila. Che pensa Borgese di Quasimodo?
(La redazione di Epoca, composta da giovanissimi, da giovani e da anziani)
Conosco di Quasimodo Ed è Subito Sera. Dice cose tristi e serene, dunque due volte vere, in una lingua trasparente d’incantevoli echi da quella sua Sicilia che parlò Greco.
Sillabe d’ombre e foglie.
Sull’erbe abbandonati
si amano i morti,
….
In me un albero oscilla
da assonnata riva,
alata aria
amare fronde esala.
Vorrei sapere se secondo Borgese è possibile conciliare lo storicismo hegeliano con l‘esistenzialismo di Kierkegaard. (Arturo Riva, Genova)
Non mi pare possibile. Kierkegaard, salvo errore, è un intransigente dualista, Hegel è un triadista, cioè in fin dei conti un monista, e il due non si concilia col tre se non dentro e sotto il tre. Però su cose di questo genere l’interrogante dovrebbe chiedere più soddisfacenti risposte a Cantoni. (La Coscienza inquieta).

