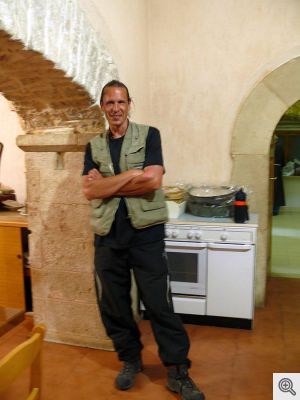La via Francigena
Durante il medioevo sia l’Appia che la Traiana forse assumono anch’esse il nome di Via Francigena. Inizia così un flusso di pellegrini tra i paesi franchi e il Santuario Garganico, considerato come meta finale o come tappa intermedia prima di imbarcarsi per la Terra Santa. Sarà proprio la difficoltà di raggiungere i Sacri luoghi, dopo la fine dell’epoca crociata o per altre ragioni, a far sì che Monte Sant’Angelo diventasse, per lunghi periodi, la meta del Pellegrinaggio. La si poteva raggiungere con vari percorsi, così come si evince dai racconti degli antichi pellegrini illustri. Secondo diversi autori il più frequentato partiva da Roma per poi dirigersi verso Benevento, dopo aver attraversato Anagni, Frosinone e Montecassino. Da Benevento proseguiva verso Ariano Irpino per poi immettersi lungo gli itinerari che conducevano al Gargano. Il Prof. Infante (Nota 161) ci parla dei reticoli di strade percorse dai pellegrini verso il Gargano, Il gruppo Terre Alte del CAI (Club Alpino Italiano) di Benevento e di Foggia (Nota 162) individua un percorso con riferimenti storico-culturali che legittimassero un certo itinerario, attingendo a studi e ricerche effettuate dal Prof. Giorgio Otranto e dai docenti del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università di Bari, dal Prof. Pietro Dalena dell’Università della Calabria, 


Strata francigena vengono denominate, nel 1201, anche altre due tratti di vie, di cui una è detta maiore, che passavano nei pressi di Tressanti, e quindi all’incrocio della via che da Foggia conduceva a Salpi con la via Litoranea che proveniva da Siponto (Nota 167). Si tratta, con molta probabilità, della stessa strada che prosegue sino a Bari, dove viene denominata 'ruga Francigena' in un documento del 1153 (Nota 168).
Tra le diverse strade che attraversavano il territorio di Casalinovo è ricordata nei primi decenni del XIII sec. una viam Francisce (Nota 169).
Lungo questo tratto di via Francesca sono dislocati vari eremitaggi di origine altomedievale che fanno parte dei tanti eremi del Gargano occidentale (Nota 172). Una via, insomma, che non è semplicemente una striscia da percorrere, ma è un intero sistema strategico che innerva profondamente un complesso di spazi circostanti e che presuppone, evidentemente, una precisa presenza di insediamenti, guarnigioni, stanziamenti, un rapporto, cioè, molto più stretto di quanto si possa pensare, tra la popolazione residente e il gruppo di dominatori.
Gli studiosi nella documentazione medievale riguardante la Capitanata ritengono che nella Daunia e sul Gargano non esistesse una sola strada francigena, ma la stessa denominazione veniva applicata a una rete di strade che mettevano in comunicazione le terre del nord Europa con il santuario garganico e i porti per imbarcarsi e raggiungere le lontane contrade del vicino e medio Oriente.
Questo evidenzia una delle caratteristiche delle reti viarie medievali, configurabili, per lo più, come un ventaglio di varianti e derivazioni da un asse centrale di antica origine. Il nome francigena fa riferimento, quindi, non a percorsi ben prestabiliti, ma a un’area di Stratae, di Viae e di sentieri che conducevano alla medesima destinazione. Il fatto che si tratti delle stesse denominazioni adoperate per il reticolo delle strade più importanti del medioevo che, dal mondo dei Franchi, conducevano pellegrini, mercanti, eserciti e privati viaggiatori (Nota 173) (Il grassetto è del redattore, ndr).
Stopani (Nota 174) descrive almeno due tracciati che staccandosi dalla via Appia Traiana raggiungono Monte Sant’Angelo l’uno a Buonalbergo, l’altro a Sant’Eleuterio giungevano il primo a San Severo attraverso i territori di Volturara, San Bartolomeo, Castelnuovo, Fiorentino, il secondo a Lucera passando da Castelfranco in Miscano, Roseto Valfortore, Tertiveri (Nota 175).
Mentre Carella sostiene che 'la principale via di accesso a Monte Sant’Angelo fosse quella di Siponto e non la via che dalla valle di Stignano, passando per San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, giungeva infine al santuario' (Nota 176).
La Via Francigena nella Capitanata, o sul 'Monte Gargano' meriterebbe, secondo alcuni studiosi, il titolo di cammino di pellegrinaggio europeo. La speranza dello storico medievalista Cosimo Damiano Fonseca, che la suddetta Via sia dichiarata d’interesse europeo dal Consiglio dell’Europa, si appoggia su questa semplice valutazione: 'la nostra non è una strada che si può definire dalla semplice frequentazione di un popolo, bensì una Via che ha unito nel nome di Dio per molti secoli, come tutti i tratti della Via Francigena, i popoli d’Europa'.
Si accenneranno ad alcune ipotesi d’interpretazione, rimandando ad altri studi di approfondimento, per avere un quadro di sintesi della questione in modo da poter collocare nella giusta misura le proposte di studio avanzate in modo da poter presentare una proposta valida d’itinerario spirituale e culturale per i moderni pellegrini e camminatori che si devono saper compenetrare le varie possibili esigenze e aspettative, ma si deve creare anche una valida risposta alle molteplici esigenze del territorio che deve poter esprimere la sua cultura e la sua fede (Nota 188).
I percorsi della Via Francigena della Capitanata, secondo Longo, possono essere delineati schematicamente, all’interno di due itinerari: l’uno a prevalenza storico sociale, l’altro a prevalenza storico religiosa.
Lo studio sui possibili itinerari della 'Via dei pellegrini' in Capitanata è ancora aperto e non concluso.
I percorsi sono così delineati:
- Il percorso che da Benevento (Nota 189) arriva a Siponto e a Monte Sant’Angelo tramite leantiche vie romane: Benevento-Aecae-Lucera-Arpi-Siponto (Nota 190).
- Il percorso che dal Sannio arrivava a Larino, Geronum, attraversava il Fortore e Teanum Apulum, arrivava alle falde del Gargano Occidentale per proseguire nella valle di Stignano e addentrarsi nel Gargano (Nota 191).
- Il percorso che dalla Litoranea adriatica toccava Pleutum (Chieuti), Ripalta, Apricena San Giovanni in Piano, Stignano e proseguire nella direzione est nel Gargano.
- Il percorso sui tratturi e tratturelli della transumanza che da Ripabottoni arrivava a Torremaggiore, e poi proseguiva nella valle di Stignano e arrivava a Monte Sant’Angelo (Nota 192).
- Il percorso che lasciava l’antica via Litoranea romana a Sant’Eleuterio (Ergitium) (Nota 193) e arriva a Monte Sant’Angelo attraverso la valle di Stignano, San Marco in Lamis, SanGiovanni Rotondo (Nota 194).
- Il percorso che seguiva la via Litoranea romana oltrepassando Ergitium proseguiva lungo la zona pedegarganica fino a Villanova e salendo il piccolo zoccolo in quella zona passava per Madonna di Cristo oppure lasciando la via Litoranea a Ciccallento si passava per San Iorio e salendo il piccolo zoccolo del Calderoso e delle Matine si passava prima per San Cristofaro e poi per Santa Restituta e infine saliva il monte Gargano, la comodità di questo percorso era nel non attraversare le valli garganiche e immettersi dalla via litoranea sui tracciati della transumanza (Nota 195).
- Il percorso che dall’Irpinia arriva a Siponto attraverso l’innesto alla via Appia nei pressi di Benevento, si inseriva nel Subappennino Dauno verso Bovino e proseguiva per Troia-Lucera-Arpi-Siponto. E’ detta anche la “Strada di Puglia” (Nota 196).
- Il percorso che da Benevento toccava Aecae-Arpi-Siponto fino ad arrivare a Monte Sant’Angelo era di circa 145 Km, ma in questo percorso bisognerebbe considerare che in alcuni periodi era difficile guadare i torrenti in piena per la mancanza di ponti in alcuni tratti.
- Il percorso che da Benevento arriva a Monte Sant’Angelo attraverso la seguente via: Benevento - San Marco dei Cavoti - San Bartolomeo in Galdo - Pietramontecorvino - San Severo - San Marco in Lamis - Monte Sant’Angelo (Nota 197).
- Il percorso che da Benevento arriva a Monte Sant’Angelo attraverso la seguente via: Benevento - Ariano Irpino - Volturara - Castelnuovo - Monfalcone - Roseto - Biccari - Torremaggiore - San Severo - Stignano - San Marco in Lamis - San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo (Nota 198).
- I percorsi che staccandosi dalla via Appia Traiana raggiungevano Monte Sant’Angelo attraverso due vie, la prima da Buonalbergo - Volturara - San Bartolomeo in Galdo - Castelnuovo - Fiorentino - San Severo- Monte Sant’Angelo; la seconda da Castelfranco in Miscano - Roseto Valfortore - Tertiveri - Lucera - San Severo - Monte Sant’Angelo (Nota 199).
- Il percorso garganico che da Ripalta sulla Litoranea si immetteva a Santa Maria della Selva della Rocca e proseguiva per San Nicola Imbuti, la grotta di san Michele di Cagnano e nei territori del Gargano interno raggiungeva il santuario di Monte Sant’Angelo.
- Il percorso che dalla Litoranea vicino Apricena saliva a Castelpagano e nei territori del Gargano interno raggiungeva San Egidio a Pantano e poi il santuario di Monte Sant’Angelo.

Indubbiamente i percorsi terrestri principali si inserivano nella Montagna sacra da Siponto oppure da Stignano.
Il prof. Piemontese (Nota 200) dice: 'Recentemente, tuttavia, attraverso alcune pubblicazioni (Corsi, Infante, Bertelli) riguardanti i percorsi su cui sono sorti gli insediamenti micaelici in Italia, si tenta di sottovalutare o negare del tutto l'importanza della Via Sacra Langobardorum, confutandone il significato e la stessa esistenza. Il tutto a vantaggio di una generalizzazione degli itinerari micaelici, sorti lungo la Via Francigena. Noi invece, siano convinti che fu propria [sic!] la presenza dei Longobardi nell'Italia meridionale a dare origine alla Via Sacra Langobardorum, che era ben differente dal percorso canonico della Via Francigena o Via Francesca. Con i Longobardi, infatti, si ebbe un grande sviluppo del pellegrinaggio micaelico da Benevento al Gargano, tanto da creare una vera e propria "strata peregrinorum", che prenderà, in seguito, la denominazione di Via Sacra Langobardorum. E tale noi la chiameremo, in quanto la presenza qualificante e determinate dei Longobardi nell'Italia centro-meridionale, ha determinato la nascita di una vera e propria civiltà e cultura legata al culto micaelico, civiltà che sopravvivrà anche dopo la scomparsa della Longobardia Maior, ad opera di Carlo Magno (742-814), mentre essa continuerà nella Longobardia Minor, fino all'XI secolo, con al centro la città di Benevento, da cui parte e si sviluppa la Via Sacra Langobardorum. Del resto di una "strata peregrinorum" longobarda, si parla già al tempo della regina Ansa, moglie di Desiderio (756-774), la quale aveva dato disposizione affinché i pellegrini diretti al santuario di San Michele sul Gargano avessero la massima protezione da parte delle autorità. Ciò lo si ricava dall'Epitaphium Ansae reginae, riportato dallo storico longobardo Paolo Diacono nella sua opera Historia langobardorum'.
A tale proposito così scrive il prof. G. Otranto: 'Tra le tante strade secondarie che facevano corona alla Traiana, assunse particolarmente importanza la cosiddetta Via Sacra Langobardorum, denominazione che non ha riscontro in epoca medievale, ma viene abitualmente usata dagli studiosi moderni per indicare la via che penetrava nel Gargano da sud-ovest e che era percorsa principalmente dai Longobardi di Benevento per raggiungere la grotta dell'angelo di cui erano particolarmente devoti: per questo fu definita sacra. Nel tratto terminale, passava per l'antica Ergitium, nelle vicinanze di San Severo, attraversava la valle di Stignano, raggiungendo l'attuale convento di San Matteo a San Marco in Lamis, per poi proseguire verso San Giovanni Rotondo, da dove, attraverso la valle di Carbonara, convogliava i pellegrini, che confluivano da tanti diverticula laterali, verso la grotta-santuario'.
Il prof. Infante (Nota 201) dichiara che 'la documentazione storica e archeologica attesta, nella piana del Tavoliere, la presenza di numerose strade che mettevano in collegamento la costa tirrenica con quella adriatica attraverso i valichi appenninici e le regioni del nord con quelle dell’estremo sud della penisola italiana. Le più documentate, dagli itinerari di viaggio e dalla presenza di strutture di accoglienza, sono la via Appia Traiana e la via Litoranea. Sono ulteriormente attestate altre strade che collegavano il percorso appenninico più interno dell’Appia antica con l’Appia Traiana: la Herdonitana che sfruttando la valle del torrente Calaggio collegava Eclano ad Herdonia, e la Venusia-Herdonia.” Il prof. Infante sostiene che “la fondazione del santuario garganico nel V sec. e altri eventi in epoca medievale mutarono in parte l’assetto viario della regione. Se la via Appia Traiana mantenne a lungo la sua funzione, acquisì sempre più importanza, a motivo degli interessi longobardi per la costa adriatica, il collegamento diretto tra Benevento e Siponto, lungo il tracciato breve che seguendo il corso del torrente Celone tagliava fuori Lucera. Questo tragitto incrociava, per quanti si dirigevano al santuario garganico, quello della via Litoranea all’altezza del casale Candelaro e della domus hospitalis di San Leonardo. Di qui iniziava la salita verso Monte Sant’Angelo. Per quanti provenivano dalla costa adriatica, al santuario micaelico si poteva, però, accedere direttamente dalla strada che, percorrendo la valle di Stignano fino a San Matteo, dopo il valico di monte Celano, passava da San Giovanni Rotondo, Sant’Egidio, San Nicola e giungeva a Monte Sant’Angelo da valle Carbonara. Queste due vie non erano certamente le uniche che conducevano i pellegrini al sacro speco attraverso la Daunia. Di certo sono le più attestate sia per le testimonianze documentarie sia per le strutture di accoglienza sorte lungo il percorso. Il prof. Infante specifica che 'coloro che viaggiavano per mercanzia o non avevano, comunque, di mira una visita al santuario garganico, l’alternativa era di prendere da Troia la via di pianura che, passando da Foggia, consentiva di raggiungere più rapidamente la costa adriatica in prossimità dell’antichissima città di Salpi'. 'i nomi di via francigena (o franchigena) e via francesca, attribuiti nella documentazione medievale, sia alla strada di pianura che da Troia, passando per Foggia, conduceva a Siponto e poi a Monte Sant’Angelo, sia al percorso che, giungendo dalla costa molisana, saliva al santuario garganico, attraversando prima la valle di Stignano e toccando poi San Matteo e San Giovanni Rotondo, sia ancora alla via che da Troia, attraversava la piana del Tavoliere e si ricongiungeva alla Litoranea pervenendo poi a Bari, pur riferendosi, perciò, a itinerari differenti hanno sostanzialmente un identico significato. I due nomi, gli unici attestati nei documenti, sono intercambiabili e praticamente coincidono, come si evidenzia dal documento rogato a Termoli nel 1024. Si tratta di strade percorse da gente che viene da lontano, d’oltralpe, da pellegrini e viaggiatori che hanno in qualche modo a che fare con i Franchi. Il tragitto più frequentato dai pellegrini che volevano salire al santuario micaelico, sembra fosse quello che, seguendo la via Appia Traiana fino a Troia, se ne distaccava per giungere al promontorio garganico attraverso la piana del Tavoliere.
Ciò però non toglie che anche sulle altre vie francigene transitassero pellegrini d’oltralpe per salire a Monte Sant’Angelo'.
Il Paolucci indica che dopo Benevento la direttrice si divideva in tre direzioni. Sono le cosiddette “Vie dell’Angelo” i percorsi che, attraverso i valichi dell’Appennino, conducono tutti al santuario di San Michele sul Gargano. Il tracciato più meridionale tocca Troia, […] percorrendo la via dell’Angelo mediana, arrivavano a Lucera … La via dell’Angelo più settentrionale da Benevento porta a San Severo di Puglia e da lì a San Michele Arcangelo, in vetta al Gargano.
Per nessuna realtà stradale medioevale, come per la Via dei pellegrini all’Angelo Michele, siano valide le osservazioni di Giuseppe Sergi, secondo cui nessuna grande strada medievale può concepirsi come un percorso unico e definito, ma piuttosto in senso dinamico come un «asse viario», nel quale confluiscono vie secondarie, cioè come «area di strada» o «fascio di strade», che possono avere un percorso prevalente. Così intesa, per l’Italia meridionale, la via dei pellegrini finisce 'col coincidere con quella complessa rete viaria che, fondendo le tradizioni dei due Santi, si potrebbe denominare Cammino dell’Angelo e di San Nicola, nel nome dei quali, durante il medioevo, si è creata una sorta di koiné culturale e religiosa tra Europa centro-settentrionale, Italia, Mediterraneo bizantino e Terrasanta'.