I cattolici per bene
Con l’articolo apparso il 21 giugno 2005 sull’"Unità" (2) Paolo Flores D’Arcais ha avviato un discorso di questo tipo. Il mio taglio è diverso ma l’obiettivo è lo stesso. Essere spietatamente franchi significa evitare come la peste ogni ipocrisia e ogni rispetto umano. Si sentono fare sia da laici sia da cattolici dichiarazioni nobilissime, quasi commoventi: gli uni e gli altri si indignano per le nefandezze degli uomini, ma poi agiscono in modo ignobile. Si tratta solo di "apparire", non di "essere". A mio giudizio anche Carlo Marx è colpevole, gravemente colpevole, di indignazione strumentale, cioè di ipocrisia: denuncia con parole di fuoco le nefandezze dei "borghesi" ma poi, machiavellicamente, consiglia ai comunisti di praticare nefandezze anche peggiori per il trionfo della rivoluzione.
Il fine giustifica i mezzi? Non è vero: mezzi barbari imbarbariscono il fine stesso.
Quando la signora in nero si presenterà al mio cospetto, la tratterò - mi auguro di essere coerente - con cortesia e con "arguzia", come dice e come probabilmente ha fatto il mio amico Adamo Smith e come certamente ha fatto il mio amico e maestro Gaetano Salvemini il quale, quando stava per "chiudere gli occhi alla luce", ebbe la visita di due studentesse che si accostarono trepidanti e commosse al maestro che stava per morire (e lui lo sapeva bene): "Come siete carine! - disse. - Se mi rimetto vi sposo tutte e due".
Ho conosciuto negli anni molti preti, alcuni missionari, alcuni vescovi, e ho avuto con loro ottimi rapporti.
Ho conosciuto diversi politici democristiani che erano credenti, e per certi periodi ho collaborato con loro: il rapporto di stima era reciproco. Sulla Chiesa di Roma debbo ammettere che faccio fatica a dimenticare i lunghi periodi bui: l’Inquisizione e le torture, la politica che, in quanto azione di Stato, puntava sulle potenze straniere e ha quindi reso impossibile per secoli l’Unità d’Italia. Faccio fatica a dimenticare le nefandezze commesse dallo Stato pontificio che usava la religione come instrumentum regni.
Ho tanti anni addosso: sono nato nel 1920. Mia madre era una donna genuinamente religiosa, intelligente e intrepida. Mio padre era, per educazione, blandamente cattolico, era antifascista e quindi - dopo l’ "uomo della provvidenza" - sempre più ostile alle gerarchie ecclesiastiche, non alla religione in quanto tale. La madre di mia madre era la sorella di Giustino Fortunato, un liberale vero che si rese immediatamente conto del pericolo rappresentato dal fascismo.
Ruppe col suo amico Benedetto Croce, che per anni fu decisamente filo-fascista al punto da votare, al Senato, a favore di Mussolini dopo l’assassinio di Matteotti. Solo in seguito, col Manifesto degli intellettuali, Croce divenne il vessillo dell’antifascismo; se avesse assunto subito quella posizione forse avrebbe contribuito a bloccare il fascismo, la sua influenza era enorme.
Sono stato allevato in quel clima.
Dopo l’8 settembre 1943 tornai a Roma e mi iscrissi a un gruppo di partigiani. Ma il mio tentativo di fare l’eroe è fallito ed eccomi qua.
Ero riuscito a laurearmi nel luglio 1942 con una tesi, scelta da me, sui rapporti tra innovazioni e sviluppo economico. Nel preparare la tesi conobbi Adamo Smith economista, solo molti anni dopo ho conosciuto Smith filosofo. Concorsi a una borsa di ricerca e la vinsi e nel ’48 andai in America per un anno. Ad Harvard, dove insegnava Joseph Schumpeter, aveva insegnato storia anche Gaetano Salvemini. Mio padre, che era antifascista e pugliese come Salvemini di cui aveva una stima grandissima, mi presentò a lui con una lettera.
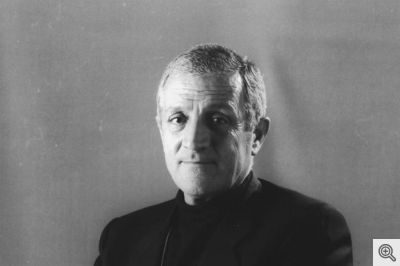
Quando tornammo in Italia andai spesso a trovare Salvemini a Firenze e, negli ultimi anni della sua vita, a Punta di Sorrento dove era ospite dei suoi cari amici.
Qualche volta veniva a Roma, ospite di Ernesto Rossi, suo amico intimo e allievo. Andandolo a trovare conobbi Ernesto e stabilii un’amicizia che è durata fino alla sua scomparsa. Salvemini e Rossi erano visti come "mangiapreti". In realtà erano anticlericali e quando incontravano un fervente cattolico che fosse un uomo civile lo rispettavano senza riserve. Ecco quello che Salvemini scrisse di don Sturzo - la citazione fu fatta da don Tonino, vescovo di Molfetta, il 6 ottobre 1988, in occasione delle giornate salveminiane promosse dal Comune di Molfetta, amministrato da democristiani (il sindaco mi aveva invitato a tenere la relazione di base).
Forse l’anima pulita del suo laicismo la si può cogliere in questo splendido giudizio che egli dà su don Sturzo:
Il clericale domanda la libertà per sé in nome del principio liberale, salvo poi sopprimerla negli altri, non appena sia possibile, in nome del principio clericale. Don Sturzo non è clericale. Ha fede nel metodo della libertà, per tutti e sempre. È convinto che, attraverso il metodo della libertà, la sua fede prevarrà sull’errore delle altre opinioni per forza propria, senza imposizioni più o meno oblique.
E questo, credo, era quel terreno comune di rispetto alla libertà di tutti e che rese sempre possibile la nostra amicizia, al di sopra di ogni dissenso ideologico.

